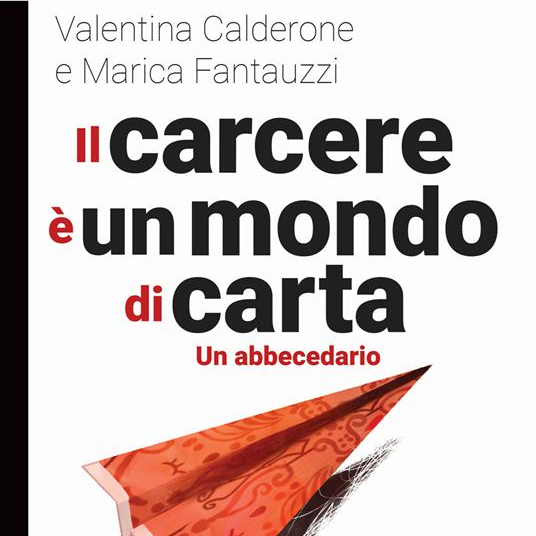…ma in carcere esiste la felicità?
È la domanda che una bambina di otto anni ha rivolto a Valentina Calderone e Marica Fantauzzi, autrici di Il carcere è un mondo di carta. Questo volume, illustrato da Ginevra Vacalebre e arricchito dai contributi di Luigi Manconi (leggi la postfazione di Manconi) e Giusi Palomba, affronta domande che spesso anche noi adulti ci poniamo sulla vita in carcere.
Noi de Il Randagio, che ci lasciamo guidare nel nostro percorso dai dubbi e dalle curiosità, abbiamo scoperto che “Il carcere è un mondo di carta”, non solo offre risposte adatte a tutti, “grandi e piccini”, ma, attraverso parole e immagini, ci fornisce una chiave anche per superare eventuali pregiudizi. Il libro suggerisce che l’alternativa al carcere può essere costruita insieme, trasformando la giustizia e promuovendo il cambiamento sociale.

Se il carcere, come recita il titolo del vostro libro, è un mondo di carta, chi sono i carcerati?
Valentina: I carcerati o – come preferiamo dire – le persone detenute sono uomini, donne, minori, che, nella maggior parte dei casi, rispondono a categorie sociali ben definite. L’immaginario collettivo pensa spesso che il carcere raccolga persone che hanno commesso atti di grandissima pericolosità sociale; quella che invece è l’evidenza, andando “dentro”, conoscendo le persone, parlando con loro, è che le persone che vivono in carcere sono, nella maggior parte dei casi, stranieri, persone con problemi di salute mentale o di dipendenze. Sono persone che la nostra società non vuole vedere “fuori”, di cui non sa prendersi cura, per le quali pensa che la soluzione sia rinchiuderle dentro un posto, un po’ per toglierle dal nostro sguardo, un po’ perché non sa bene cosa farne. Non sa bene come affrontare tutta la complessità sociale, che nelle nostre città, nel nostro Paese e nel mondo esiste. Il carcere diventa una soluzione non efficace a problemi molto più complessi e che non riguardano esclusivamente l’idea del male che abbiamo noi.
Cosa pensate si debba conoscere delle donne, degli uomini e dei minori che si ritrovano a vivere per mesi, anni o il resto della loro vita in quel “mondo di carta”?
Marika: credo che la prima cosa da conoscere sia la storia, la vita prima, durante e dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Le biografie personali hanno un peso decisivo per capire le traiettorie che porteranno all’istituzione carceraria. Conoscere queste vite innanzitutto permette di averne per certi versi meno paura, perché avvicinando queste persone si capisce che in molti casi quello che è successo a loro potrebbe effettivamente capitare a persone a noi vicine o a noi stessi. Allo stesso tempo, si mette in discussione una convinzione assoluta per la quale noi società civile, opinione pubblica associamo il carcere alla giustizia, laddove invece molto spesso, conoscendo quelle storie di detenuti si capisce che questa associazione tra giustizia e carcere è piena di falle e inciampa su se stessa più e più volte. La conoscenza delle storie aiuta quantomeno a sviluppare una visione critica del carcere.
A questo punto vorrei chiedervi come siete riuscite a mettere insieme la leggerezza della carta con la pesantezza della reclusione?
Valentina: Vale la pena di dire due parole sul titolo, che per noi ha un doppio significato. Il significato più immediato è che la vita delle persone detenute passa attraverso dei fogli di carta, che vengono chiamati in gergo, le “domandine” (qui ci sarebbe da aprire una parentesi sul linguaggio penitenziario e su come anche il linguaggio contribuisca a rendere queste persone non uomini, non donne, non minori). Ogni necessità in carcere va autorizzata e ogni richiesta, ogni esigenza viaggia attraverso un foglio di carta. E le carte fanno dei giri tortuosi, devono essere firmate, devono arrivare alla persona giusta, poi tornare indietro con una risposta e possono volerci settimane o mesi. A volte le carte si perdono… La soluzione dei problemi dei detenuti dipende da quella carta. L’altro aspetto però è che la carta è molto fragile, la si può deformare, si può rompere, si può appallottolare oppure – come nella copertina di Ginevra Vacalebre – si può fare un aeroplanino e lo si può lanciare. Ed è un po’quello che volevamo trasmettere, l’idea che l’istituzione carcere non è un’Istituzione data per sempre, che le istituzioni si possono modificare – forse prima di tutto nelle nostre teste – provando a fare un percorso per renderci conto che probabilmente non abbiamo così tanto bisogno del carcere come è oggi e come lo pensiamo. È un’istituzione come tante altre e come tutte le cose umane si possono cambiare, si può anche pensare che eventualmente possano sparire. Invitiamo a riflettere che questa pesantezza data dall’architettura carceraria, questi muri molto grandi, questi cancelli, queste chiavi, la pesantezza del ferro e del cemento, in realtà nascondano la fragilità di quell’Istituzione. E su questa fragilità si può costruire un percorso che ci porti a idee alternative.

E intanto i diritti di queste persone che fine fanno?
Marika: i diritti di queste persone, a proposito di carta, in realtà sono quelli previsti dalla Carta costituzionale, sanciti dall’articolo 27, per cui una pena non può essere lesiva della dignità dell’essere umano. A cascata ne segue tutta un’altra serie di diritti che fa capo alla persona detenuta, tra cui il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione. Ma l’istituzione carceraria attuale è evidente che non riesca a tener fede all’articolo 27 e quindi scricchiola tutto l’impianto di diritti immaginato dai padri e dalle madri costituenti.
Qual è il percorso che avete seguito per arrivare a capire che quel mondo di carta possa essere sostituito?
Valentina: pensiamo all’efficacia delle misure che vengono messe in campo rispetto all’individuazione di un problema. Il carcere è un posto che separa dalla società chi ha commesso un reato, e quindi una delle domande da porsi è: come è possibile insegnare, reinserire, rieducare al reingresso se separiamo nettamente le persone dalla società? Ci sono strumenti, misure alternative al carcere che provano ad avere uno sguardo diverso e a includere l’autore del reato all’interno di una situazione comunitaria, che possono essere per esempio i lavori di pubblica utilità. Ci sono poi i “tentativi” introdotti dalla riforma Cartabia che riguardano per esempio la giustizia riparativa e che provano a costruire un dialogo tra chi ha commesso il reato e chi lo subisce. Avere una prospettiva abolizionista significa provare a capire in che modo interrompere un ciclo di violenza. Noi crediamo che sia molto importante far sapere quanto le carceri siano endemicamente, costituzionalmente violente: non è costruendo il carcere migliore del mondo che questa violenza riusciamo ad eliminarla. Occorre provare ad astrarci un po’ dalla contrapposizione tra perdono e vendetta, che sono sentimenti umani, emozioni. Ma le emozioni non dovrebbero essere prese come spunto per governare questi fenomeni, per costruire politiche. Credo invece che dovremmo provare a ragionare in termini di riparazione, in termini di giustizia trasformativa, che è un concetto a noi molto caro. Dovremmo riconsiderare il reato come a qualcosa che avviene all’interno di una comunità, che la ferisce e di cui però la comunità stessa si deve prendere la responsabilità. E siamo molto grate a Giusy Palomba, che ha scritto un bellissimo libro su questo e che abbia deciso di scrivere anche la nostra prefazione.
Quindi, se capisco bene, guardate a un sistema della giustizia che si possa risanare proprio attraverso la riconciliazione tra vittime e colpevoli.
Valentina: nel libro che ha la forma di un abbecedario la “V” si sdoppia in “vittime” e “vendetta”. Quando si parla di questi temi il rischio è sempre quello di sentirsi dire “sì, però a voi non ve ne frega niente della vittima”. Io penso che la vittima – sarebbe meglio dire “il sopravvissuto” o il sopravvivente -, chi sopravvive al reato abbia tutto il diritto di sentirsi ferito, di non avere alcuna intenzione di avere un contatto o un confronto, di provare rabbia per tutta la vita. Questa componente è assolutamente delicata e del tutto personale. La possibilità di incontro deve essere totalmente libera. Però io penso anche che ci meritiamo come collettività di poter accedere a degli strumenti che ci aiutino a gestire e a elaborare la rabbia, il dolore, la frustrazione, che peraltro non fanno bene a nessuno. E allora provare collettivamente, a livello sociale, a trovare degli strumenti di elaborazione collettiva, di trasformazione può portare un benessere a tutte le componenti della società.
Il vostro libro ha la forma di un abecedario e fa pensare che si rivolga soprattutto ai più giovani. A chi si rivolge esattamente?
Marika: il libro è rivolto a tutte le fasce di età, ma con una attenzione particolare a quelli che abbiamo definito preadolescenti e adolescenti. Noi parliamo di questi temi in occasioni molto “adulte”, in ambienti lavorativi, accademici, universitari e via discorrendo, comunque tra adulti. Detto questo, ci siamo chieste se attraverso un dialogo con chi ancora è immune o comunque non completamente assorbito dalla retorica carcerocentrica; se tramite questo dialogo con delle giovani generazioni sarebbe stato possibile addirittura adottare, immaginare delle parole diverse, dei linguaggi diversi e quindi un immaginario diverso. Quindi abbiamo pensato che potesse avere senso raccontare loro quello che è dal nostro punto di vista l’ambiente carcerario, adottando una sorta di abecedario che è descrittivo delle condizioni e degli spazi detentivi. Però allo stesso tempo volevamo dire loro che la parola utopia esiste e che ci può essere qualcosa di alternativo allo status quo, che bisogna attivare tutte le energie per affrontare in maniera prioritaria il tema delle disuguaglianze.
Valentina e Marika vi ringrazio anche a nome dei lettori del Randagio per averci parlato di una tematica complicata, di grande interesse e che induce a riflettere.
Rita Mele

Rita Mele: barese, ma da molti anni vive a Bolzano. Giornalista, giurista, formatrice, psicologa, insegnante di yoga. Progetti per il futuro: ballare