Il capitale si dice in molti modi. Non consiste soltanto di soldi – risparmiati, immobilizzati, o investiti. Non è fatto, quindi, solo di case, negozi e mura, immobili per definizione. Tutto questo è “capitale economico”, che può essere contato, e che conta moltissimo. Capitale è anche l’apprendimento, scolastico e pratico; la propria esperienza di sé e del mondo, che matura in chiarificazioni dell’esistenza, riflessioni e strategie per risolvere problemi. Questa seconda forma di capitale diventa “capitale culturale”, dove “cultura” non è un inerte deposito di nozioni, ma conoscenza che si ricava attivamente dalla vita vissuta (e con cui, non meno attivamente, le si va incontro). Capitale è infine non solo che cosa si conosce, ma chi si conosce: persone che diventano contatti, contatti che diventano reti. Questa terza forma di capitale, non meno indispensabile, costituisce il “capitale sociale”.

Al sociologo francese Pierre Bourdieu dobbiamo l’articolazione di questo “triangolo del capitale”, con cui la diade marxiana struttura (economica) – sovrastruttura (cultura, “spirito”, storicità delle forme di vita) riceve feconda linfa empirica senza per questo essere sconfessata. Tutt’altro. Il capitale economico rimane sempre e comunque la base, la struttura marxianamente intesa, su cui poggia l’intero triangolo. Il modello di Bourdieu ci offre però una risorsa formidabile per comprendere la sofferenza sociale di molti esseri umani, perlomeno del cosiddetto Nord globale. La loro esistenza può essere letta come il desiderio di rendere il triangolo il più equilatero possibile, di portare ovvero in armonia i tre lati del capitale. È questo, se vogliamo, il caso di un allievo particolarmente brillante di Bourdieu (e di Michel Foucault) come Didier Eribon.
Tanto in Ritorno a Reims quanto nel più recente Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo (trad. Annalisa Romani), Eribon dà voce al dolore che si sprigiona dall’essere nato e quindi stato socializzato in condizioni di ristretto capitale economico e di non meno esiguo capitale culturale (intendendo qui il termine nel senso più “scolastico” del medesimo) in seno alla classe operaia della provincia francese, e dal suo sentirsi altro, estraneo, diverso, rispetto a tale ambiente – il che condurrà Eribon medesimo a diventare, a discapito di ogni determinismo socio-economico, professore universitario di sociologia, e, con ciò, un vero e proprio “transfuga di classe”.
Vi è infatti una fuga, una migrazione, tanto concreta quanto interiore, che avviene tra il venire al mondo in un preciso milieu sociale, e l’anelare e spingersi verso ambienti che distano anni luce da esso. Si genera una tensione peculiare, in cui l’individuo si trova a lottare, non senza un certo eroismo tragico, contro pressioni sociali d’ogni sorta. Il succitato determinismo socio-economico sorveglia e schiaccia ogni eccezione che abbia l’ardore di sfidarlo. Quella di Eribon diventa allora una storia di successo a fronte, per usare un altro termine di Bourdieu, della “riproduzione” intergenerazionale (padre ricco-figlio ricco, padre povero-figlio povero), con cui tutto, nel campo sociale, pare dire: “Stai al tuo posto!”
La peculiarità di Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo sta nel dare voce a “storie che non fanno la Storia” (per dirla con un altro stimolante testo, appena uscito, di Carlo Greppi). Nel raccontare la vicenda biografica di una donna, la madre del sociologo, esponente del proletariato industriale novecentesco, che mai avrebbe affidato il proprio vissuto a un resoconto scritto, Eribon compie un gesto di altissimo valore ermeneutico e civile. Egli incarna il compito dell’intellettuale nel senso gramsciano del termine, come colui che dà voce ai senza voce, e, raccogliendo le loro testimonianze, cerca di comprendere gli anelli che non tengono delle nostre strutture sociali, depositando, proprio in tale sforzo interpretativo, il seme per far nascere il nuovo, ovvero, per un mondo più giusto.
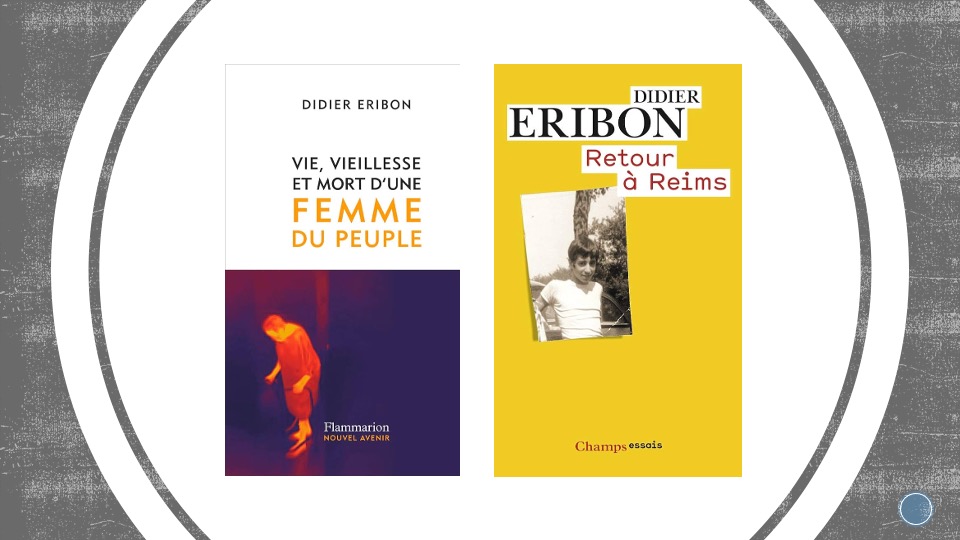
Senza infingimenti, con una sensibilità millimetrica per il singolo gesto, Eribon apre per noi stanze di vita quotidiana che rimangono solitamente serrate, in quanto privatissime o irrilevanti. Ci consegna i commenti razzisti borbottati da una donna ottuagenaria della campagna francese (sua madre) davanti alla televisione, allorché vi vede delle persone nere, e quelli sessisti di un uomo cinquantenne (suo fratello), che si rifiuta categoricamente di sortire i vestiti dall’armadio della madre defunta, in quanto compito da lui reputato incongruo al suo status di maschio. Ma il libro di Eribon offre anche, al tempo stesso, una capillare denuncia delle condizioni inumane delle case di riposo, e pone il dito in una piaga di cui le nostre società non vogliono farsi carico, neanche mentale: il processo d’invecchiamento, e, per dirla con Norbert Elias, “la solitudine del morente”.
Al tempo stesso, il libro si segnala come un tentativo, accorato ma mai patetico, di riconciliazione. Laddove Ritorno a Reims poteva essere letto come un processo di riconciliazione con sé stesso, con cui un intellettuale omosessuale parigino compie un viaggio a ritroso che lo condurrà a fare i conti con la provincia operaia da cui il suo itinerario di vita e pensiero avrebbe preso le mosse, sottraendosi alla “riproduzione” socio-economica, Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo mantiene palpitante la tensione riconciliatoria del precedente volume, e la amplia, rivolgendola a quell’altro-da-sé sui generis che è colei che ci ha ospitati per nove mesi e dunque gettati nel mondo. Nei confronti della madre, Eribon vuole, in qualità di autentico uomo della conoscenza, innanzitutto capire. Capire: non sentenziare né assolvere. Capire anzitutto quali sono le condizioni di possibilità e i limiti della massima di Sartre “noi siamo quello che facciamo – di quello che ci è stato fatto”, che in casi fortunati (come il suo) si volge in agency, ma innanzitutto e perlopiù si traduce invece in forme di (per dirla invece con Adorno) “vita offesa”, in cui non si diventa affatto quel che si è, e il proprio romanzo di formazione si torce in un triste racconto di de-formazione.
Ci troviamo allora dinnanzi a due socio-biografie, in cui il testo della vita della singola persona diventa il pre-testo per comprendere un’epoca storica e i suoi dispositivi socio-economici e cultural-spirituali. L’individuale diventa il luogo di rivelazione del generale, a partire dal particolarissimo di minimi gesti quotidiani. La grande Storia universale, dicevamo prima, s’incarna di volta in volta in singole storie particolari, che non fanno la Storia. Eppure, si capisce probabilmente di più il secondo Ventesimo e il primo Ventunesimo secolo leggendo Didier Eribon che attraverso molte analisi quantitative in terza persona. La circostanza odierna, per cui “i ceti subalterni votano contro i loro interessi”, per riprendere una sentenza che viene lanciata, come vero e proprio gemito sofferente, da un altro anziano morente, interpretato da Silvio Orlando in Un altro ferragosto di Paolo Virzì, affligge sicuramente molti lettori del Randagio, e resta sovente, non meno dolorosamente, senza risposta. Dalle pagine di Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo non traiamo risposte universali e necessarie, ma scopriamo cosa porta una esponente in carne ed ossa delle classi sociali più svantaggiate a dare il proprio consenso politico a movimenti che invocano un autoritarismo di matrice fascista, alternandolo a quello assegnato a partiti più (apparentemente) rispettabili. E scopriamo come l’attuazione di policies neoliberiste e la conseguente erosione dei diritti del lavoro fondamentali attuata dai secondi (risoluta è la critica di Eribon al Presidente Macron in tal senso) costituisca la condizione fatale di possibilità dei primi.
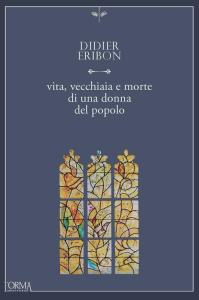
La riflessione di Eribon innescata dalla vicenda sociobiografica di sua madre diventa allora estremamente eloquente, ancor più se la si collega ad alcuni termini chiave di un certo pensiero liberale, veri e propri miti del tardo Ventesimo secolo, che l’autore in vero non tematizza esplicitamente, ma che ci aiuta, con i suoi scritti, a mettere nella giusta prospettiva. Pensiamo a vocaboli-mantra come “autorealizzazione”, “meritocrazia”, “resilienza”. Questi termini, dall’apparenza emancipatrice, sono in realtà assai sovente nient’altro che lusinghe sottilmente mendaci. il primo suona: “Da grande potrai fare tutto ciò che vuoi!” – ma non tiene conto degli ostacoli sistemici lungo il cammino, su tutti la succitata riproduzione. Il secondo esorta: “Se uno è bravo alla fine ce la fa!” – ma in realtà appiattisce l’essere al fare, ovvero alla riuscita professionale, per cui accetta tacitamente che un essere umano è il mestiere che fa, il che è fonte di quella lancinante sofferenza descritta in Ritorno a Reims. Il terzo insiste: “Se vuoi, puoi” – ma in realtà è un ulteriore dispositivo di controllo, con cui si chiede al lavoratore, già abbastanza precarizzato e sfruttato, financo di sorridere, come un provetto ballerino, mentre cerca di fare l’impossibile affinché “tutto rimanga come esattamente è”, oppure, senza scomodare il buon vecchio Gattopardo, per rimanere a galla.
Francesco Ferrari

Francesco Ferrari è ricercatore e docente presso l’Università Friedrich Schiller di Jena; è coordinatore dello Jena Center for Reconciliation Studies; è autore di tre monografie dedicate al pensiero di Martin Buber e di vari saggi su e traduzioni di autori della filosofia e della cultura ebraica del XX secolo (tra cui Arendt, Buber, Derrida, Landauer, Scholem, Zweig); svolge attività di ricerca sul concetto di riconciliazione dopo Auschwitz, ed è editore dell’epistolario di Martin Buber nel progetto Buber-Korrespondenzen Digital.
https://www.jcrs.uni-jena.de/about/team/dr-francesco-ferrari
https://francescoferrari.academia.edu/

