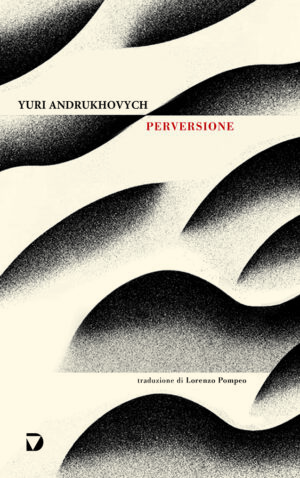Venerdì 8 settembre 2023 Mantova – Festival Letteratura
Sono arrivata in bicicletta davanti alla hall dell’hotel in cui soggiorna Gazmend Kapllani, sarà colpa del caldo o forse dell’emozione, ma mi sento le mani umide e i battiti del cuore fortissimi. Vedo Gazmend uscire dall’ascensore, ci presentiamo: io mi sento un po’ goffa nei convenevoli, mentre lui è da subito molto gentile e disponibile alla conversazione. Ci sediamo al tavolino di un bar, perché ogni conversazione che si rispetti inizia sempre davanti a un buon caffe… e per magia tutto comincia.
Gazmend tu conosci benissimo la Storia con la “S” maiuscola che hai vissuto da protagonista, ma hai scelto di utilizzare il linguaggio della narrazione. La tua scelta è quella di restituire ai lettori l’esperienza delle frontiere dal punto di vista del singolo, che però viene eletto come universale. Non è il fenomeno storico, ma è come il singolo vi si trova all’interno a fare la differenza ed è ciò che tu esplori con la tua scrittura.
Vero, mi interessa di più ciò che noi chiamiamo “microstoria”, ovvero come la storia interagisce con le nostre vicende personali creando uno spazio che spesso rimane silenzioso, non detto. Provengo da una nazione, l’Albania, in cui negli anni del totalitarismo l’identità dei singoli fu cancellata in maniera molto violenta, perciò amo esplorare quei territori mai raccontati e schiacciati dalla storia. Questo per me è il senso della letteratura: raccontare le vicende delle persone comuni, dare vita a dei personaggi per poi chiedersi di ognuno di loro: chi era? da dove veniva? come si connetteva con gli altri? quali erano le sue illusioni, percezioni, che desideri e paure aveva. Scrivo per raccontare la commedia dell’esistenza.
Questo per me è il punto di partenza per fare letteratura. Se la storia si interessa agli archivi, la letteratura si interessa prima di tutto all’evoluzione umana ed è ciò di cui mi occupo.

La terra sbagliata, il tuo ultimo romanzo, è la storia di un ritorno in patria. Un fratello ritorna a casa dopo la morte del padre. Spesso i migranti rientrano in patria quando muore un famigliare. Il ritorno è conflittuale non solo per chi è emigrato, ma anche per chi è rimasto e tu lo racconti attraverso i punti di vista di due fratelli: quello che è restato nel paese d’origine e quello che torna dopo vent’anni di assenza. Tra l’altro, hai ambientato la tua storia in una cittadina immaginaria chiamata TERS, che in albanese significa “malocchio”, perché questa scelta?
La letteratura dell’Est è sempre stata caratterizzata da una forte dose di ironia e fatalità: da qui la mia decisione di dare quel nome al paese del mio romanzo. Ciò in parte ha ragioni storiche perché è conseguenza della distopia con la quale la gente dell’Est è stata costretta a vivere durante i regimi totalitari. L’Albania è stata per molto tempo considerata una terra di frontiera e la storia con questi popoli non è mai stata molto gentile. Ho ambientato il mio romanzo in un paese immaginario perché il ritorno per un emigrato è per sua natura qualcosa di fortemente immaginario: non si ritorna mai nello stesso modo in cui si è partiti. Chi ritorna ha una percezione diversa della gente e del proprio luogo d’origine: è un rapporto caratterizzato sempre da una forte tensione.
In Albania durante il totalitarismo tutta la letteratura dell’Occidente era censurata. Mi ha colpito sapere che hai tradotto e diffuso di contrabbando la traduzione del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. È la storia di un soldato, una storia di obbedienza. Ho provato a mettermi nei tuoi panni, a pensare di essere un ragazzo che voleva scappare da una nazione dove c’era una dittatura e mi sono chiesta perché hai scelto questo libro.
I libri di contrabbando che ci cadevano nelle mani erano davvero molto rari. Ci consideravamo molto fortunati ad avere anche uno solo di questi, erano assolutamente necessari per poter nutrire il nostro spirito, la nostra intelligenza e la nostra immaginazione.
Quei libri erano atti di resistenza contro l’oppressione, contro il “deserto culturale” che subivamo. Quando lo lessi la prima volta mi impressionò moltissimo per l’angoscia esistenziale che restituiva, per quell’illusione e quel senso di attesa, in cui io mi riconoscevo completamente. Tutto il libro è una metafora incredibile dell’esistenza umana, di una bellezza struggente una forza immensa. Le mie letture “di contrabbando” sono state assolutamente cruciali per la mia decisione di diventare scrittore. È molto interessante constatare che tutti i regimi totalitari vedano la letteratura come qualcosa di fortemente pericoloso perché sviluppa il pensiero critico, l’individualità e la libertà.
Tu ora vivi a Chicago dove insegni Letteratura delle Frontiere a una generazione che non ha vissuto la guerra fredda. Come vedi il rapporto delle nuove generazioni verso le frontiere?
Ogni generazione ha una percezione differente delle frontiere e dipende anche di quale frontiera stiamo parlando. In Europa per esempio c’è una generazione che cresce senza l’angoscia delle frontiere che avevo io, i miei genitori e i miei nonni. Le nuove generazioni hanno un concetto molto più globale del mondo rispetto a quello che avevamo noi, che era molto isolato e frammentario; i giovani d’oggi affrontano nuovi dilemmi e nuove forme di emarginazione. Considero una frontiera moderna l’appartenenza o no a nazioni che dispongono di armamenti nucleari, perché ciò presuppone il potere di scatenare o no una guerra nucleare e la scomparsa dell’umanità sulla terra. Io insegno la storia dell’evoluzione delle frontiere che oggi sono soprattutto culturali, perché per i giovani di oggi i confini non sono più geografici, ma di natura sociale perciò invisibili. Posso comunque affermare che ancora oggi il concetto di Frontiera affascina le nuove generazioni: l’immigrazione resta uno dei fenomeni più sconvolgenti nel nostro mondo; ma ora rispetto a 50 anni fa, ha una portata globale che influenza continuamente la nostra percezione quotidiana del mondo in cui viviamo, variando continuamente i concetti di identità, nazione e continente. Abbattere le frontiere oggi ha una consapevolezza diversa rispetto ai nostri tempi: le sfide di oggi sono su scala mondiale.
Un’ultima domanda: tu sei un grandissimo lettore, qual è il libro a cui ritorni e che più ti ha ispirato nel tuo lavoro di scrittore e poeta? Abbiamo tutti un libro del cuore, un libro riconciliante, il tuo qual è?
Non è soltanto un libro. Diversi scrittori mi hanno influenzato e penso che i maggiori vengano dall’Est. Scrittori come Milan Kundera, Danilo Kis, Jaroslav Hasek con le avventure del Bravo soldato Svejk. Nel mio passato di isolamento in Albania, la lettura è stata fondamentale per la mia sopravvivenza, di quel periodo ricordo che leggevo le Poesie di Jaques Prevert che hanno avuto un’enorme influenza su di me e ancora mi capita di ritornare a lui.
Federica Scaltriti