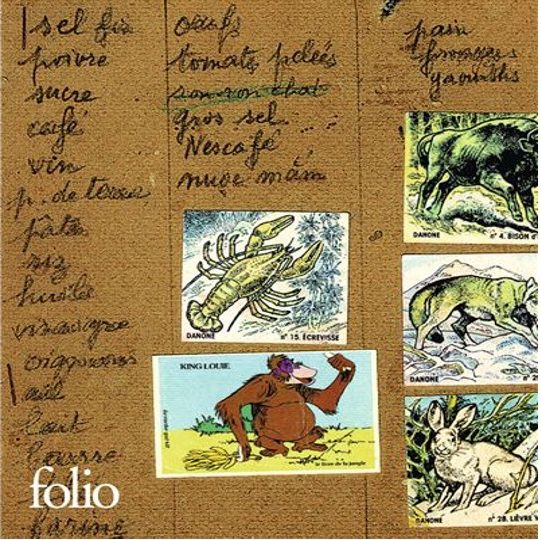TORNARE A CASA. Marguerite Duras, La vita materiale e bell hooks, Elogio del margine
Abitare una casa.
Se poser, insediarsi delicatamente, costruire un involucro protettivo, chiudendosi una porta alle spalle; serrato lontano il mondo, con le sue asperità, respiriamo.
Abitare una casa.
Se poser, insediarsi delicatamente, trovare riparo in un’isola di senso, dove far crescere le idee e, attraverso una geometria di relazioni, spalancarsi al mondo.
Due modi di abitare che hanno in comune la casa come focolare ma che divergono nell’attimo in cui la porta chiusa alle spalle diventa zattera con cui traghettare verso un oltre da costruire.
Due modi del posizionamento delle donne in quel margine/periferia che è la casa, luogo crudele e tenero al contempo, attraversato senza posa da cure materne preoccupate di dar vita a un nido caldo.
La casa come microcosmo, cellula emotiva, luogo identitario, rifugio e prigione insieme.
La casa come spazio di resistenza, di opposizione al sistema per non lasciarsi assalire e assimilare.
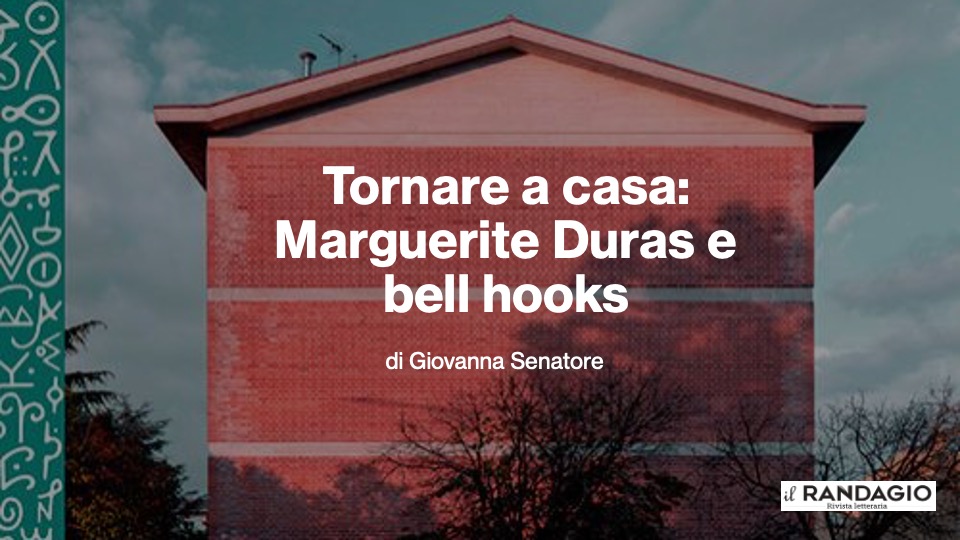
Marguerite Duras e bell hooks, hanno decostruito il discorso sul focolare domestico, donandoci punti di vista destinati a incrociarsi e divergere nello stesso tempo.
Due autrici radicali che hanno tessuto la loro vita con la scrittura in una continua presenza a se stesse per cui ogni parola resa tra case abitate, cinema, aule universitarie, interviste, riflette il gioco acrobatico di non lasciarsi mai chiudere in forme stereotipate, nei poteri delle accademie o dei gruppi politici, accettando la sfida di essere oltre, parlando di amore, e di conflitto, del nostro corpo che invecchia, della morte ma anche della vita, perché la parola e la costruzione politica nascono nelle pieghe della nostra esistenza nelle cose che ci accadono e nei nostri sogni e desideri.
Marguerite Duras ha ricapitolato in se stessa il ‘900: il colonialismo, due guerre mondiali, la Resistenza, il femminismo, le avanguardie artistiche; gli uomini e le donne voracemente frequentati, gli amici da Godard a Lacan; il successo letterario e cinematografico; gli anni terminali devastati dall’alcol. Una vita lacerata, sempre inchiodata a un dolore non medicabile, la relazione con una madre che amò e odiò disperatamente per esserci stata, per non esserci stata. E di questa relazione è densa la casa tratteggiata in La vita materiale. Essa porta scalfita l’impronta materna, si fa spazio utero che accoglie, che nutre; arruffata e morbida, piena di angoli per ospitare, ha come centro la cucina e i suoi attrezzi, i ciuffi di lavanda seccata, le macchinette del caffè, le minestre da cucinare, la verdura da pulire.
“La casa è la casa di famiglia, serve a mettere i bambini e gli uomini per trattenerli in un posto fatto per loro, accogliere il loro smarrimento, distoglierli dallo spirito di avventura, di fuga, di cui sono dotati dall’origine dei tempi. Quando si affronta questo argomento, la cosa più difficile è raggiungere quel materiale liscio, senza asperità, che è il pensiero della donna intorno all’impresa pazzesca rappresentata da una casa. Quella della ricerca del punto di convergenza comune ai figli e all’uomo. Il luogo stesso dell’utopia è la casa creata dalla donna, quel tentativo a cui lei non sa resistere, e cioè di interessare i suoi cari non già alla felicità ma alla sua ricerca.”
La casa che protegge è spazio esclusivo delle donne, teatro di una messa in scena volta a garantire lo star bene dei suoi abitanti; l’impegno nelle faccende domestiche, lungi dall’affondare la donna nella noia, diventa nell’ottica durassiana il tempo dell’ordine; fare la spesa, riordinare la casa, cucinare, dà vita a un ordine esteriore in grado di anticipare e favorire l’ordine interiore.
“L’ordine esterno e l’ordine interno della casa. L’ordine esterno, cioè l’assetto visibile della casa, e l’ordine interno che è quello delle idee, dei livelli sentimentali, dell’eternità di sentimenti verso i figli. Una casa come la concepiva mia madre, era per noi, in realtà. Non penso che avrebbe fatto lo stesso per un uomo né per un amante.”
La casa dentro, la casa materiale deve dare a chi la abita la certezza che, in quel nido caldo e protettivo, niente potrà mai accadere, fin quando a vigilare sarà la donna -madre dispensando tutto quello che occorre “per andare avanti, vivere, sopravvivere.”
Operando sul corpo della casa come un chirurgo col bisturi sul corpo ammalato di un paziente, la donna dovrà renderla sempre accogliente sgombrandola di tutto ciò che la sovraccarica, la ingombra; ma, gettare via, è arte non semplice da conquistare.
Comporta la rinuncia a tutto il dismesso tesaurizzato in armadi, bauli, cantine, dalla contabilità delle bollette pagate, agli abiti non più usati ma che un giorno, (quando?) potremmo rindossare, ai giocattoli, impolverati e speso rotti ma testimoni di un tempo che la memoria colora di magico. Forse, sembra suggerirci Duras, la tensione a inscatolare nasconde il tentativo di erigere un monumento a noi stesse, “ai nostri meriti”, a quella fatica titanica di dispensare cura irreggimentando il nostro tempo su quello degli altri. Totem fragile, pronto a dissolversi senza lasciare traccia perché la radice profonda nel quale affondano le donne è l’oblio di sé e l’impossibile felicità.
La casa guscio mostra così, pian piano, il suo lato oscuro, il buco nero nel quale la donna rischia di precipitare quando si fa spazio di torpore, di straniamento, dove corpi e vite vengono e si lasciano governare in una strisciante microfisica di poteri.
“Forse la donna secerne l’intima sua disperazione lungo le maternità, i vincoli coniugali. Forse perde il suo regno nella disperazione di ogni giorno, e questo per tutta la vita. Forse le sue aspirazioni di gioventù, la sua forza, il suo amore l’abbandonano defluendo proprio dalle piaghe fatte e ricevute nella più assoluta legalità. Forse è così. Forse, per la donna, si tratta di martirio. E la donna completamente realizzata nella dimostrazione della sua abilità, della sua sportività, della sua cucina, della sua virtù, è da buttare dalla finestra.”
Se la maternità è l’unico significante femminile, se la casa è il luogo dove coltivarlo, ci dice la Duras che la periferia, il margine da noi abitato è un posto dove si vive male, perché quel bimbo, quella bimba che teniamo in braccio alla fine si allontanerà dal nostro seno e guarderà altrove, vedrà il mondo, vorrà esplorarlo e incontrare qualcun altro e noi ci sentiremo inutili:
“Nella maternità la donna abbandona il proprio corpo al bambino. E i bambini le stanno sopra come su una collina, come in un giardino, la mangiano, la picchiano, ci dormono sopra e lei si lascia divorare.”
Di questo lungo banchetto cosa resta?
Forse solo lo scandalo della domanda.

La contraddizione tra il sogno di una casa come luogo dove tessere affetti e il bisogno di chi la abita di oltrepassare il limite, di andare oltre verso il mondo esterno, perché quella casa è anche lo spazio della paura e della solitudine trova un nuovo modo di essere declinata in bell hooks.
bell hooks: bell come la madre, hooks, come la bisnonna materna, minuscole entrambe le iniziali. Nella singolarità della scelta del nome con cui firmare le sue opere e la sua vita di attivista politica, femminista, nera, Gloria Jean Watkins, connota subito se stessa e la radicalità del suo pensiero. Due nomi femminili vengono intrecciati, a sfidare il patriarcale codice dei nomi declinato lungo l’asse maschile per dare vita a una genealogia costruita su “una lunga discendenza di donne schiette e volitive”, da celebrare sottraendole all’oblio.
Chi sono queste donne cancellate dalla storia? Perché raccontarle?
Per dipanare il filo teorico di bell hoks è necessario partire dal luogo della sua nascita, Hopkinsville, Kentucky, una città come tante del Sud rurale e segregato degli Stati Uniti, nei primi anni ’50. Lì, il sistema di apartheid era disegnato da una ferrovia che tagliava giorno e notte lo spazio. Di giorno i neri attraversavano i binari per andare a lavorare per i bianchi, la notte tornavano da dove erano venuti, al loro posto, in un pendolarismo silenzioso e agghiacciante che disegnava confini e regime economico.
“I binari della ferrovia sono stati il segno tangibile e quotidiano della nostra marginalità. Al di là di quei binari c’erano strade asfaltate, negozi in cui non potevamo entrare, ristoranti in cui non potevamo mangiare e persone che non potevamo guardare dritti in faccia. Al di là di quei binari c’era un mondo in cui potevamo lavorare come domestiche, custodi, prostitute, fintanto che eravamo in grado di servire, ci era concesso di accedere a quel mondo, ma non di viverci.”
In quella comunità separata, in una famiglia di sette figli, governata da un padre- padrone violento e dal silenzio rassegnato della madre, si costruisce il suo sguardo e la sua posizione nel mondo, nel solco della doppia oppressione che attraversa la comunità dei neri e la sua famiglia: la discriminazione razziale e l’asimmetria tra ruolo paterno e materno, tra parola maschile e silenzio femminile, entrambi espressione del patriarcato capitalista.
“Poiché il sessismo delega alle donne il compito di creare l’ambiente domestico e di provvedere ad esso, è stato soprattutto grazie alle donne nere se il focolare domestico si è costruito come spazio di cura e nutrimento da contrapporre alla feroce, disumana realtà dell’oppressione razzista, della dominazione sessista.”
Qui il pensiero di bell hook erode la storia da sempre narrata, la graffia nelle sue impalcature dando parola e significato politico alla resistenza silenziosa messa in campo dalle donne nere, trasformando la casa nel luogo della cura e della protezione:
“era dentro le case che si produceva tutto ciò che conta nella vita- il calore e la pace di un luogo dove sentirsi al sicuro, cibo per i nostri corpi, nutrimento per le nostre anime. È lì che abbiamo imparato ad avere fede. A renderci possibile questa vita, facendoci da guida e da maestre, sono state le donne nere.”
Maestre non attraverso l’articolazione di principi teorici messi in scrittura (moltissime erano analfabete) ma nel silenzio e nella solitudine delle loro azioni; al ruolo sacrificale da sempre loro attribuito dal sessismo per cui essere madri è solo l’incarnazione perfetta della naturale condizione femminile, hooks oppone la visione della libertà della scelta, e della re-visione tanto del ruolo quanto dell’idea di casa esercitata volontariamente dalle donne nere nella loro pratica.
Non un destino biologico a legarle al focolare faticosamente custodito ma la volontà di erigere luoghi dove tutti i neri potessero lottare per essere soggetti, non oggetti, dove, nonostante la povertà, la fatica, le privazioni, la dignità, che all’esterno veniva negata, potesse essere restituita.
Ripensando alla sua infanzia, alla porta che si chiudeva inesorabile dietro le spalle della madre, costretta come la maggior parte delle donne nere a servire nelle case dei bianchi, hooks scrive:
“Al suo rientro, dopo lunghe ore di lavoro, non si lamentava. Faceva di tutto per farci capire quanto fosse contenta di aver concluso la sua giornata di lavoro, di essere a casa; ma nello stesso tempo ci dimostrava che nella sua esperienza di lavoro come domestica al servizio di una famiglia bianca, in quello spazio di Alterità, non c’era nulla che le togliesse la sua dignità e il suo potere personale.”
Così la casa, àncora per i passi stanchi dei chilometri percorsi dalle donne nere per ritornare dai loro figli, si fa casa radice pronta a dipanarsi su un terreno che non aspetta altro che dare vita a nuovi frutti.
Casa dove accatastare fumo, libri, sciarpe, scarpe, umori, caffè, cibo, risate, pianti. Pareti dove parlare, porsi domande, nodi da sciogliere e riannodare: come sarà il tempo che verrà, come saremo in grado di costruire un mondo comune, come congiungere il pensare a un fare, un cercare una verità sempre da dirsi amalgamata alle tracce di vita che l’accompagnano, una riflessione che sappia abbracciare le azioni materiali, dal cucinare al discutere raccattando bambini che corrono o si accasciano addormentati, stufi della vita dei grandi.
Giovanna Senatore

Giovanna Senatore: laureata in Filosofia, ha insegnato Storia e Filosofia nei licei classici; formatrice in corsi di aggiornamento per i docenti lungo due tematiche: la letteratura attraverso lo sguardo del pensiero femminista, l’uso dello spazio e del linguaggio teatrale. Ha guidato laboratori teatrali in qualità di esperta in vari istituti scolastici. Fonda l’associazione culturale “Le macchine desideranti” curando la regia di tredici spettacoli dove corpi e parole possano colpire nella loro nuda e secca forza. Ha curato laboratori di scrittura a partire da testi incrociati di scrittrici che hanno ricamato tessiture preziose.