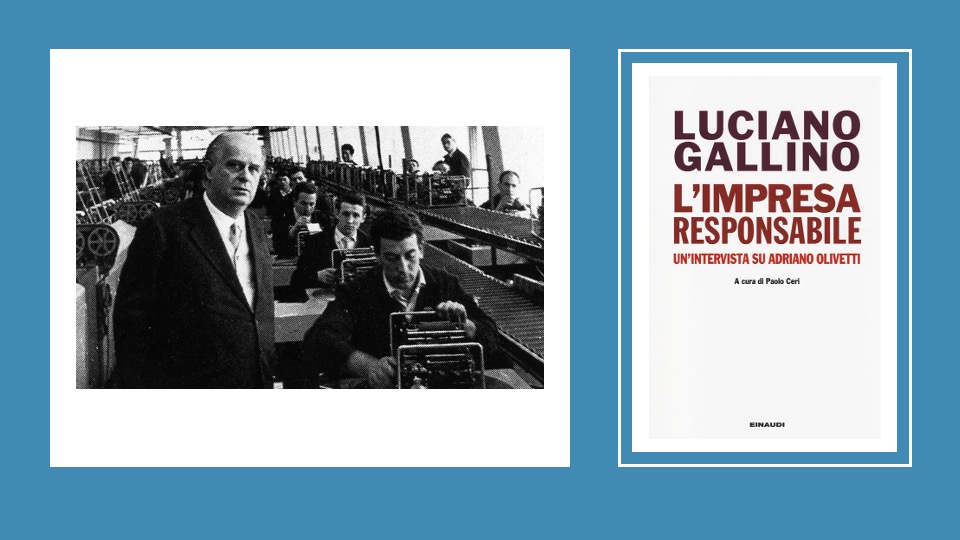Fu così che la divisione elettronica della Olivetti e il suo straordinario team di ingegneri produssero non solo il primo computer italiano, ma il primo computer completamente a transistor della storia.
Il “Programma 101” fu il primo desktop computer commerciale programmabile. Un prodotto rivoluzionario, dotato di tastiera, periferica integrata per la stampa di dati e istruzioni e un lettore di schede magnetiche, che una volta programmate, permettevano di memorizzare informazioni e comandi. Anche la Nasa, che preparava le missioni di allunaggio del programma Apollo, ne comprò dieci esemplari.
Gli Stati Uniti non apprezzarono per nulla l’intraprendenza dell’azienda di Ivrea e Olivetti forse non seppe mai che la sua azienda era sotto stretta osservazione della Central intelligence Agency diretta, a quel tempo, da Allen Dulles. Dal punto divista americano, Olivetti non era solo un inguaribile sognatore, non era solo inutile: era pericoloso.

All’apice del successo l’azienda di Ivrea acquistò la Underwood (Hartford, Connecticut) per molti anni leader mondiale indiscussa delle macchine da scrivere, con lo scopo prevalente di utilizzarne l’imponente rete commerciale e penetrare nel vastissimo mercato statunitense: non era mai successo, sino a quel momento, che un’azienda italiana ne acquisisse una americana, soprattutto di quelle dimensioni. Ciò significava che l’Olivetti-Underwood avrebbe raggiunto il livello dei competitor americani quali la Royal MacBee e la Smith Corona Marchant, se non quello di giganti per le macchine d’ufficio come la IBM. La storica acquisizione aveva messo l’azienda di Ivrea nella posizione unica e al tempo stesso paradossale, di società italoamericana pronta a vendere informazioni potenzialmente strategiche al nemico.
Il punto critico fu raggiunto quando Adriano Olivetti cominciò a sondare nuovi mercati oltre la cortina di ferro: i paesi del blocco sovietico, Russia inclusa, che offrivano un enorme potenziale di crescita e la Cina comunista di Mao Tse Tung.
Gli Stati Uniti potevano permettere che la cosa continuasse?
Il prepotente ingresso della Olivetti nel mondo dell’elettronica aveva generato negli Stati Uniti un autentico allarme e Adriano Olivetti e i suoi ingegneri erano entrati nel mirino: la società di Ivrea era ormai classificata dall’establishment Usa come “società informatica canaglia”. Episodi di sabotaggio, come il furto del prototipo del modello P101 poco prima del debutto newyorchese fecero da prologo dell’attacco risolutivo all’azienda di Ivrea.
La sequela di eventi che portò la Olivetti a chiudere i progetti di ricerca sui computer, proprio mentre l’azienda era all’apice del successo mondiale, ebbe come snodo decisivo la strana morte di Adriano Olivetti, il 27 febbraio 1960, avvenuta sul treno che lo portava in Svizzera, dove egli cercava un finanziamento per lo sviluppo dell’azienda. Una morte del tutto improvvisa (emorragia cerebrale? infarto?) che suscitò una quantità di sospetti in quanto originata da cause mai definite: non fu neppure disposta l’autopsia della salma, né risulta che la famiglia ne abbia mai fatta richiesta. Quando, pochi mesi dopo, fu chiaro che malgrado la fine di Adriano Olivetti l’obiettivo non era stato centrato, toccò a Mario Tchou, l’altro genio della divisione elettronica, scomparire dalla scena. Egli aveva rilanciato la sfida con un successo strabiliante, tanto da voler concretizzare i rapporti con la Cina, ma ciò potè bastare a decretarne la fine che avvenne a causa di un singolare incidente stradale, anch’esso mai chiarito nelle dinamiche che lo provocarono, il 9 novembre 1961.

A proposito della morte di Tchou, Bruno Amoroso e Nico Perrone scrissero nel loro Capitalismo predatore:
“Abbattuta la quercia (Adriano) restarono i cespugli in crescita che lui aveva seminato e curato. Mario Tchou portò avanti il suo progetto con successo e questo, molto più delle altre attività industriali, era una spina nel fianco della concorrenza europea e statunitense. Si trattava inoltre di un settore sensibile per gli aspetti militari e di sicurezza che conteneva, e che il clima di guerra fredda certamente esasperava. Tutto procedette bene fino a quando, il 9 novembre 1961, questo giovane ingegnere morì a 37 anni in uno strano e tragico incidente stradale. Anche in questo caso – evenienza che suscitò qualche dubbio fra amici e collaboratori – l’evento fu rapidamente archiviato come incidente: si trova nel mucchio dei misteri italiani protetti degli omissis espliciti o impliciti del potere in italia”[1].
Carlo De Benedetti, che nel 1978 assunse il ruolo di presidente dell’Olivetti, carica che detenne per vent’anni, affermò nel 2013 di essere convinto che Tchou fosse stato assassinato, ma questa era la persuasione diffusa in Olivetti.
Tre anni più tardi fu la volta di Giuseppe Pero, nel frattempo divenuto Amministratore delegato e Presidente della società, prima della capitolazione dell’azienda di Ivrea.
La morte dei principali artefici del miracolo industriale olivettiano e la debolezza della famiglia, portarono all’epilogo: il passaggio di mano dell’azienda.
Ciò che era implicito nelle morti annunciate dei protagonisti del progetto olivettiano divenne esplicito nel 1963, quando il Gruppo di Intervento composto da alcune aziende italiane guidate da FIAT, Pirelli e da Mediobanca fece chiudere la divisione elettronica. Quell’acquisizione fu in effetti ideata per distruggere la società. FIAT e Pirelli, determinanti nel Gruppo di Intervento, restituirono un favore agli americani:
“Quelle società avevano beneficiato degli ingenti aiuti economici previsti dal Piano Marshall, e ogni buona azione merita di essere ripagata, Poi, nella primavera del 1964, Valletta si rivolse agli azionisti sostenendo che la divisione elettronica della Olivetti era una macchia, “un neo da estirpare”[2].
Nel corso di un’intervista registrata nel 2000 con Matteo Olivetti, il figlio di David[3], disse che Enrico Cuccia[4], il patron di Mediobanca, aveva subìto pressioni esterne per chiudere la divisione elettronica, e che tali richieste erano partite dall’intelligence statunitense e dalla stessa IBM[5].
Nel 1964 la produzione dei grandi elaboratori venne ceduta alla General Electric da parte del Gruppo di intervento. Fu così che Fiat, Pirelli, Mediobanca e Imi completarono il lavoro sporco per conto degli Stati Uniti.
Bibliografia
Luciano Gallino, L’impresa responsabile, un’intervista su Adriano Olivetti, a cura di Paolo Ceri, Einaudi, 2001
Pier Giorgio Perotto, P101, Quando l’Italia inventò il personal computer,Edizioni di Comunità, 2015
Nerio Nesi, Le passioni degli Olivetti, Aragno, 2017
Maurizio Gazzarri, Elea 2003, Storia del primo calcolatore elettronico italiano, Edizioni di Comunità, 2021
Meryle Secrest, Il caso Olivetti, Rizzoli, 2019
Antonella Tarpino, Memoria imperfetta. La comunità Olivetti e il mondo nuovo, Einaudi, 2020
Paolo Bricco, Adriano Olivetti, un Italiano del Novecento, Rizzoli, 2022
Umberto Serafini, Adriano Olivetti e il Movimento Comunità, Edizioni di Comunità
Valerio Ochetto, Adriano Olivetti, Marsilio, 2009
Bruno Amoroso e Nico Perrone, Capitalismo predatore, Castelvcchi, 2014
Adriano Olivetti, Dall’America: lettere ai familiari, Edizioni di Comunità, 2016
Adriano Olivetti, Il dente del gigante, Edizioni di Comunità, 2020
Adriano Olivetti, Edizioni di comunità:
Democrazia senza partiti
Il cammino della comunità
Ai lavoratori
Le fabbriche di bene
Noi sogniamo il silenzio
[1] Meryle Secrest, Il caso Olivetti, Rizzoli, 2019, pagg. 322-323
[2] Ibidem, pagg. 323-324
[3] David Olivetti, nipote di Camillo Olivetti, storico fondatore dell’omonima azienda di Ivrea
[4] Per anni la banca di investimento milanese Mediobanca e il suo presidente Enrico Cuccia furono al centro di un’intricata ragnatela di partecipazioni incrociate. L’influenza del riservatissimo Cuccia permeò il ristretto universo familistico del capitalismo italiano, incardinato in quello che passò alla storia come il “salotto buono”: due parole che evocano una raffinata sala esclusiva in cui i giganti dell’industria italiana incontravano i titani della finanza per stringere opachi accordi di dominanza.
[5][5] Meryle Secrest, Il caso Olivetti, p. 324
FINE PARTE 3 DI 3
Dino Greco

Dino Greco scrittore, saggista, giornalista, è stato direttore del quotidiano Liberazione. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su Il manifesto, Rinascita, Critica Marxista, Carta, Alternative. Il suo ultimo lavoro del 2024 è “Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate Rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia” (Bordeaux)