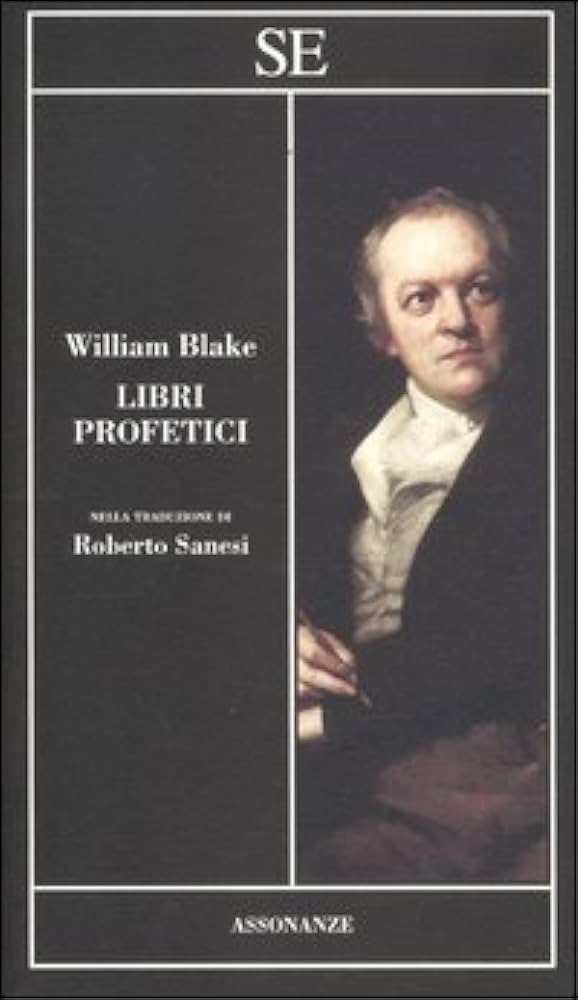Da alcuni mesi, la guerra è tornata, in Europa e alle porte dell’Europa. Riscoprire le riflessioni di un grande filosofo come Martin Buber (Vienna 1878 – Gerusalemme 1965), fermamente persuaso che la prima causa della guerra fosse l’umana incapacità di pensare la pace, è allora non solo stimolante intellettualmente, ma anche rilevante concretamente.
Il percorso umano e intellettuale di Buber ben si condensa nell’epiteto “costruttore di ponti”, tributatogli dall’allievo Ernst Simon. Egli rivolse infatti la propria vita e il proprio pensiero a riparare relazioni danneggiate tra individui e tra gruppi. Nei suoi scritti e nel suo agire, Buber si dedicò a superare l’estraniazione che separa singoli esseri umani, l’essere umano e Dio, la persona dal suo mondo sociale e culturale, popoli e stati, l’ebreo dall’ebraismo, ma anche dal cristiano, dall’arabo, dal tedesco. Gli scritti di Buber possono essere letti come una sfida alle condizioni anonime e alienanti della vita moderna, e, con il primato della relazionalità che essi affermano, ci insegnano a recuperare presenza, interezza e capacità di incontrare, in una parola: riconciliazione nelle nostre vite.

Buber era nato a Vienna l’otto febbraio 1878 da una facoltosa famiglia della borghesia ebraica di lingua tedesca dell’Impero Austro-ungarico. All’età di tre anni, sua madre Elise abbandonò il nucleo familiare: un evento traumatico, un “incontro mancato” che lo accompagnerà, come un’ombra, per tutta la vita. Il piccolo Martin venne affidato allora alle cure dei nonni paterni a Leopoli, all’estremo margine orientale della monarchia asburgica. Il nonno Salomon era un esperto editore di Midrash e di testi rabbinici; la nonna Adele, un’appassionata lettrice del classicismo e del romanticismo tedesco. In questo contesto, Buber fa conoscenza diretta del chassidismo, una corrente mistica dell’ebraismo esteuropeo che, in diversi suoi scritti, avrà modo di tematizzare nei termini di cabbalà divenuta ethos, santificazione del quotidiano e superamento dello iato tra sacro e profano. Alcune polarità peculiari del suo pensiero prendono già avvio in questi primissimi anni: germanicità ed ebraicità, ebraismo occidentale ed orientale, società e comunità, religione istituzionale e religiosità mistica.
Nel 1896 Buber torna a Vienna, per iscriversi all’università: sceglie come facoltà filosofia e storia dell’arte. Ha come maestri Georg Simmel e Wilhelm Dilthey, ed è un avido lettore di Nietzsche, Kant e Schopenhauer. Buber, però, non è affatto un intellettuale isolato in una torre d’avorio: in ogni stagione della sua vita entrerà in contatto con diversi movimenti letterari e politici. Chi vuole accostarsi allo studio del suo pensiero non può prescindere dall’analizzare i network di cui egli fu parte integrante. Una fonte particolarmente ricca a riguardo è l’epistolario del filosofo. Esso consta di oltre 40.000 lettere indirizzate a oltre 7.000 destinatari, ed è attualmente oggetto del grande progetto “Buber Korrespondenzen Digital” che, finanziato dall’Accademia di scienze e lettere di Magonza, si svolge presso le Università di Francoforte e di Jena, sotto la guida dei professori Christian Wiese e Martin Leiner.

La prima pubblicazione di Buber risale al 1897: è in lingua polacca, ed ha per oggetto scrittori viennesi come Arthur Schnitzler e Hugo von Hofmannsthal. Nei medesimi anni, la politica lo chiama, con una forza ancora maggiore: Incontri decisivi sono quelli con il pensatore e attivista anarchico Gustav Landauer e con il leader sionista Theodor Herzl. L’influsso di Landauer è rinvenibile fin da una conferenza buberiana del 1901, al cui centro sta la comunità, intesa come espressione genuina del legame tra uomo e uomo. Essa si contrappone tanto al monopolio della forza dello stato quanto all’anonimato della società: è una “comunità postsociale”. Da Herzl, Buber è invece nominato, nel medesimo anno, caporedattore del periodico Die Welt: nelle sue pagine, il giovane filosofo formula un sionismo culturale, che, incentrato sulla rinascita della creatività del popolo ebraico, contrasta apertamente la visione di uno stato ebraico propugnata dallo stesso Herzl – è il “rinascimento ebraico”. Quelli dell’università sono dunque anni indubbiamente intensi per Buber. Tra Vienna, Lipsia, Zurigo, Berlino e ancora Vienna, essi culminano nel conseguimento del dottorato nel 1904, con una tesi sul problema dell’individuazione in due filosofi cristiani: Nicolò Cusano e Jakob Böhme.
Buber trascorre un paio d’anni a Firenze, dove assiste ad alcuni spettacoli teatrali di Eleonora Duse che lo impressioneranno durevolmente, per poi stabilirsi in Germania: Dapprima nella capitale Berlino, e quindi, a partire dal 1916, a Heppenheim an der Bergstrasse, un piccolo centro non molto lontano da Francoforte. Negli anni che precedono la Prima guerra mondiale, Buber lavora come lettore per la casa editrice Rütten & Loening. Qui, diventa caporedattore della serie Die Gesellschaft (ovvero: la società), una pionieristica collana in 40 volumi a più autori, in cui è già presente il termine “interumano”, che diventerà peculiare del suo pensiero dialogico. Buber si volge quindi, con crescente intensità, a mito e mistica di diversi popoli e religioni: chassidismo, taoismo, cristianesimo medievale, induismo, islam – l’afflato della religiosità non conosce per lui limiti confessionali. La questione del senso dell’ebraismo in un mondo non-ebraico è comunque oggetto privilegiato della sua riflessione, tanto in termini religiosi quanto di identità di popolo: con i Tre discorsi sull’ebraismo di Praga egli assurge a punto di rifermento per un’intera generazione di giovani ebrei mitteleuropei. Il pensiero politico-religioso di Buber, fortemente intriso di superomismo nicciano e del culto dei popoli, ma anche di una concezione mistica-messianica dell’esperienza vissuta, fa sì che egli saluti con favore lo scoppio della Prima guerra mondiale.

A partire dalla primavera 1916, tuttavia, grazie anche alle critiche mossegli dall’amico Landauer, egli rivede le proprie posizioni lealiste e belliciste. Sulle colonne del periodico Der Jude, da lui fondato proprio nel 1916, Buber interpreta la guerra in corso come l’esito del monopolio della forza da parte di stati-nazione indifferenti alla sorte del popolo ebraico, che combatte al loro servizio in una sorta di atroce guerra civile. Buber si trova così a un crocevia: il suo distanziarsi dalla mistica e il suo congedarsi dal nazionalismo si accompagnano alla svolta dialogica del suo pensiero, che trova classica formulazione nel suo capolavoro Ich und Du (ovvero: Io e Tu), iniziato sempre nel 1916 e pubblicato nel 1923.
Con Io e Tu, Martin Buber entra nella storia della filosofia come uno dei maestri del “pensiero dialogico”. Buber definisce il dare e ricevere la parola come un evento fondamentale, tanto tra uomo e uomo quanto tra l’uomo e il divino (in particolare nella Bibbia). Il linguaggio mostra come l’Io e il Tu sono legati da un vincolo di originaria coappartenenza, per cui “in principio è la relazione”. La relazione non è tuttavia per Buber una proprietà che risiede nel soggetto, bensì è l’aprioridell’essere. Quanto chiamiamo “io” non è un punto di partenza, bensì di ritorno. “Non vi è alcun io in sé”, scrive allora il filosofo, bensì l’insuperabile differenza ontologica tra l’Io della relazione Io-Tu e l’Io della relazione Io-Esso. Nella relazione Io-Tu, l’Altro è incontrato nel pieno rispetto dell’ineffabilità del suo essere, nella sua presenza inoggettivabile, irriducibile a qualsivoglia articolazione, qualitativa o quantitativa. La relazione Io-Tu permette di rivolgersi all’Altro in un dialogo franco e senza riserve, che, in quanto tale, richiede ricettività, apertura, financo vulnerabilità. C’è dialogo dove a un appello segue una risposta. In termini etici, la relazione Io-Tu definisce allora il nostro agire come responsabilità. In termini politici, essa ha come luogo di realizzazione la comunità, la cui incarnazione concreta è localizzata da Buber nel socialismo dei kibbutz (in antitesi al comunismo dei soviet). Si tratta allora di porsi in ascolto del Tu, in antitesi a quel ripiegamento su di sé monologico che pare una modalità predefinita nella nostra media quotidianità.

La relazione Io-Tu sfida il pensiero occidentale, in cui il darsi del soggetto vuol dire separazioneda un oggetto – che ben presto diventa funzionalizzazione, strumentalizzazione, reificazione. Nei termini di Buber: una relazione Io-Esso.Il nostro essere in relazione con gli altri si compie allora in base a un’antitesi fondamentale: incontrare come un Tu oppure utilizzare come un Esso. Relazione significa in Buber dialogo, coappartenenza, ma anche differenza. Sarebbe infatti profondamente sbagliato leggere il pensiero dialogico buberiano in termini di unio mystica, di sussunzione fusionale di Io e Tu. Affinché un dialogo possa aver luogo, occorre che ognuno dispieghi la propria voce: dia-logos significa discorso di due. È nella insuperabile distinzione dell’Io e del Tu che risiede il fondamento del dialogo, cosicché chi dice dialogo dice anche diversità, e quindi dissenso. Buber stesso testimonia con la propria vita e con il proprio pensiero una concezione “agonistica” del dialogo, in qualità di ebreo di lingua tedesca, sempre e di nuovo pronto a impegnarsi in dibattiti con un Tu che di volta in volta assume le sembianze del teologo cristiano, dell’attivista palestinese, financo del membro del partito nazionalsocialista.
La critica allo stato-nazione inaugurata da Buber nel 1916 ha come esito anche una revisione del sionismo in senso teocratico: essa implica lo scioglimento del vincolo del potere temporale, contrapponendo a esso l’affermazione della sola legittimità della sovranità divina. Se Dio vige come unico legislatore, ogni Führer terreno è allora un usurpatore: non si deve pertanto confondere la teocrazia con una ierocrazia o con una teologia politica, di cui essa costituisce in vero l’opposto.Una simile prospettiva pone Buber in stretta continuità tanto con il pensiero anarchico e antipolitico di Landauer quanto con il socialismo religioso del teologo evangelico Leonhard Ragaz, da cui egli mutua la tesi per cui fede significa non obbedienza a una religione, quanto edificazione del regno di Dio qui e ora. Questo significa agire in nome di verità e giustizia, al pari dei profeti dell’Antico Israele. Per Buber, non vi è autonomia del politico dall’etico. Tale principio vale anche per la definizione delle relazioni tra arabi e ebrei nella Palestina mandataria inglese, come emerge dal suo impegno all’interno dell’associazione pacifista Brit Shalom, di cui è cofondatore nel 1925. Il messaggio della Bibbia ebraica diventa sempre più importante per Buber. Ancora nel 1925 egli dà avvio, insieme all’amico Franz Rosenzweig, a un’impresa colossale: una nuova traduzione della Scrittura in lingua tedesca, che Buber porterà a compimento nel 1961, dopo il tragico tramonto della simbiosi ebraico-tedesca.

La rilevanza delle questioni teologiche cresce progressivamente nel suo pensiero: nel 1926, Buber dà avvio a un periodico interreligioso, Die Kreatur, di cui condivide la redazione con un collega protestante e a uno cattolico. Aumenta nondimeno il suo impegno pedagogico, tanto in senso teoretico quanto con i corsi che egli tiene al Freies Jüdisches Lehrhaus, istituto per la formazione degli ebrei adulti diretto proprio da Rosenzweig. Nel 1930 Buber è quindi nominato professore di Scienza ed etica dell’ebraismo all’Università di Francoforte, senza che sia in possesso di una tesi di abilitazione: un riconoscimento, quindi, che gli viene tributato per meriti scientifici e chiara fama. Buber è in costante ascesa, una stella di prima grandezza nella cultura ebraico-tedesca della Repubblica di Weimar.
Le elezioni tedesche del 1933 cambiano tutto. In peggio, naturalmente, per Buber, che nel gennaio del medesimo anno aveva esposto il proprio sionismo teocratico al convegno “i fondamenti religiosi di un movimento völkisch”, anche in presenza di membri del partito nazionalsocialista. Con la presa del potere di Hitler, Buber è destituito dall’incarico di professore universitario fin dal 1933. Tuttavia, egli non si perde d’animo. Si batte con diverse iniziative pedagogiche in favore dell’ebraismo tedesco, che assumono i tratti di una vera e propria “resistenza spirituale”. Nel 1938 Buber migra a Gerusalemme, dove ricopre la prima cattedra di filosofia sociale presso quell’Università ebraica di cui è uno dei padri, avendo propugnato la causa della sua fondazione fin dai tempi della sua militanza sionista di inizio secolo. Ed è proprio insieme al presidente dell’Università ebraica di Gerusalemme Judas Magnes che, nel novembre 1938, Buber si fa promotore di una lettera a Gandhi, in cui pone una serie di aperti interrogativi sulla possibilità della nonviolenza in circostanze estreme come quelle della Notte dei cristalli. A pochi mesi di distanza, quasi presagendo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, egli ci consegna quindi una riflessione importante: quella per cui la pace deve essere qualcosa di più di una mera assenza di guerra: occorre, nelle sue parole, una “grande pace”, pensata e praticata in maniera proattiva.

Buber è dunque tra i primi filosofi che interpretano lo sterminio degli ebrei come un evento epocale, che impone di rimettere radicalmente in discussione la relazione tra l’uomo e Dio, anticipando di diversi anni le cosiddette “teologie dell’Olocausto”. Negli anni del Secondo dopoguerra, quindi, Buber promuove dialogo, pace e riconciliazione, tanto tra ebrei e tedeschi, ricevendo importanti onorificenze come il Premio per la pace dei librai tedeschi, quanto tra arabi e israeliani, sostenendo la causa di un binazionalismo democratico e paritetico. Le sue parole, che esprimono una ferma condanna dello strapotere del principio politico e l’auspicio di una rinascita dell’interumano, lanciano quindi, in piena Guerra Fredda, un monito a riconoscersi entro una comune umanità, affermando la fratellanza universale come valore capace di impedire che libertà e uguaglianza degenerino, rispettivamente, in un individualismo di matrice statunitense e in un collettivismo di stampo sovietico.
Negli ultimi anni della sua vita, Buber esprime sempre più intensamente la propria solidarietà a favore di gruppi subalterni, oggetto di violazioni dei diritti umani, diventando, ad esempio, membro onorario del Comitato Americano per l’Africa nel 1957, dopo essere stato contattato da Martin Luther King e Eleanor Roosevelt. Un paio d’anno dopo, egli è quindi nominato Premio Nobel per la Pace da parte del segretario delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld. Nel 1960, infine, Buber manda un significativo messaggio in occasione della morte di Adriano Olivetti, così come, nel medesimo anno, è a Firenze, dove partecipa attivamente ai Colloqui Mediterranei fondati e organizzati da Giorgio La Pira.

C’è un sintagma che condensa il lungo e per certi versi tortuoso itinerario di vita e di pensiero di Martin Buber: “Umanesimo ebraico”. Umanesimo non significa in questo caso coltivare le belle lettere in una concezione erudita o salottiera del sapere: si tratta invece di imparare a distinguere e a difendere l’umano dall’inumano. Per Buber si tratta, nella fattispecie, di un umanesimo “ebraico”, ovvero, “biblico”, ispirato da quel libro dei libri che raccoglie e testimonia l’incontro tra l’umano e il divino come evento del dare e ricevere la parola. Nel 1953, in occasione del suo discorso per il conferimento del già ricordato Premio per la pace dei librai tedeschi, egli dava un volto metastorico al proprio “umanesimo ebraico”, profilando lo stagliarsi di un fronte trasversale con cui l’Homo Humanus si contrappone all’Homo Contrahumanus. Questo è, per lui, il vero luogo di uno scontro campale, il cui epicentro è stato invece additato, con fatale errore, di volta in volta, nella diversitàculturale, religiosa, ideologica. Tale conflitto non contrappone superuomini e subumani, come affermava l’ideologia nazionalsocialista, né americani e sovietici, né ancora un sedicente Occidente ebraico-cristiano contro un Oriente musulmano o sino-indiano: in esso si combattono invece, in ogni tempo e in ogni luogo, Umanesimo e Antiumanesimo. Dinnanzi al fronte trasversale dell’Homo Humanus, tutte le configurazioni politiche incarnate dallo stato-nazione si mostrano come vestigia transeunti. A queste, Buber contrappone la propria fede nella coappartenenza Io-Tu in una comune umanità. Sfidando cinismo e sfiducia, in un mondo segnato dalla montante tirannia dell’Io-Esso e dall’inestinguibile piaga della guerra, l’ultima parola di Martin Buber è allora quella della riparazione di relazioni danneggiate: quella della “riconciliazione”.
Francesco Ferrari

Francesco Ferrari (Genova 1986) è ricercatore e docente presso l’Università Friedrich Schiller di Jena e l’Università Goethe di Francoforte; collabora con l’Accademia di Scienze e Lettere di Magonza; è coordinatore dello Jena Center for Reconciliation Studies; è autore di tre monografie dedicate al pensiero di Martin Buber e di vari saggi su e traduzioni di autori della filosofia e della cultura ebraica del XX secolo (tra cui Arendt, Buber, Derrida, Landauer, Scholem, Zweig); svolge attività di ricerca sul concetto di riconciliazione dopo Auschwitz, ed è editore dell’epistolario di Martin Buber nel progetto Buber-Korrespondenzen Digital.